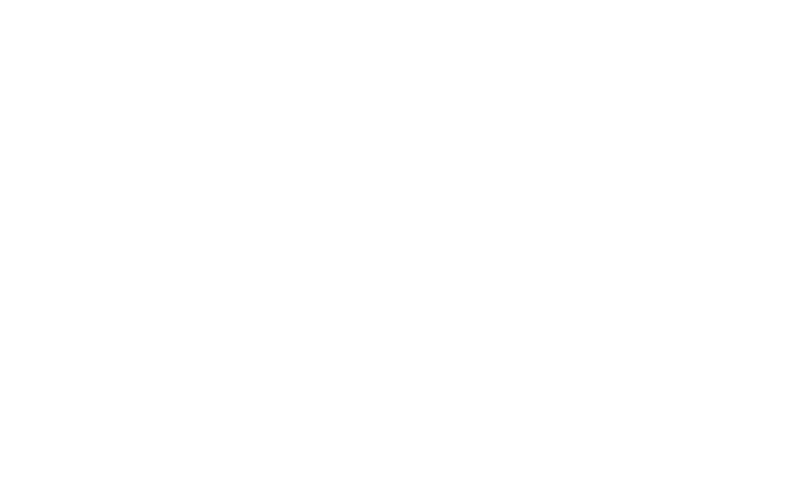Aiace, Agamennone, Oreste, Delfi
di Ghiannis Ritsos
AIACE
con Raffaele Esposito
AGAMENNONE
con Emanuele Vezzoli
ORESTE
con Massimiliano Sbarsi
DELFI
con Nanni Tormen
a cura di Walter Le Moli
Spazio Bignardi e Piccola Sala
7 novembre 2015, ore 19.00
La Grecia è la culla della civiltà, la terra dei miti che formano l’immaginario collettivo occidentale. Miti che arrivano fino ai nostri giorni con un carico di attualità che è difficile non notare, specialmente all’interno del dibattito politico contemporaneo che proprio su questo Paese si sta concentrando e sta dividendo i politici.
La visione politica è al centro del lavoro poetico di Ghiannis Ritsos, protagonista assoluto del panorama letterario ellenico del XX secolo; tormentato da vicende che lo vedono incarcerato, torturato e perseguitato per via delle sue idee e della sua fede politica, il poeta usa il mito come lente per descrivere il mondo che lo circonda. Nella sua rivisitazione dei personaggi mitologici, Ritsos utilizza i protagonisti di poemi come l’Iliade o di tragedie come l’Orestea non solo per mostrarne gli aspetti più umani e più prettamente poetici, ma anche e soprattutto per disvelarne la natura universale che non può prescindere da un discorso di protesta politica. Da questo punto di vista i monologhi (forma suprema di riflessione, che sottintende una solitudine fortemente autobiografica) riflettono sulle conseguenze della guerra, sull’ineluttabilità del destino e sul ruolo dell’individuo al suo interno, sulle passioni umane e sul senso della Storia come flusso che salva e distrugge con la stessa imparzialità. Sapientemente adattati alla scena da Walter Le Moli, i quattro spettacoli di questa kermesse offrono uno sguardo sofferto e attuale, in cui la coscienza sociale e politica va di pari passo con una sensibilità poetica altissima. Queste due dimensioni dànno a questi personaggi l’aura dell’eternità e la materia del presente.
Aiace
con Raffaele Esposito
Achille è morto, le sue armi – foggiate da Vulcano su richiesta della madre Teti per il figlio – e lo scudo meraviglioso descritto da Omero nell’Iliade, sono contese. Gli Atridi le attribuiscono non ad Aiace, figlio di Telamone re di Salamina, ma a Ulisse, giudicato il guerriero più valoroso dell’esercito. Questo motivo scatena la furia che porta l’eroe a voler trucidare tutto l’esercito greco. Solo l’intervento di Atena impedisce la strage e per punirne l’orgoglio, la dea confonde la mente di Aiace facendogli massacrare una mandria di pecore scambiata dal guerriero per i suoi compagni d’arme. Una volta rinsavito, il figlio di Telamone capisce che il suo gesto lo marchierà di un disonore inestinguibile. Recatosi sulla riva del mare, in solitudine, dopo aver invocato il sole, i fiumi della patria e i campi di battaglia su cui rifulse il suo valore, si uccide.
Questa versione della morte di Aiace è alla base della tragedia scritta intorno al 450 a.C. da Sofocle e il protagonista è appunto un uomo reso folle dall’intervento di Atena, un uomo emarginato ed escluso dal consesso dei Greci. E’ elemento di novità nel mito (nelle due tragedie perdute di Eschilo, rifacendosi all’Odissea, Aiace moriva di dolore) e risente della situazione socio-politica dell’Atene periclea: la polis poggia le sue basi su una struttura politica e sociale di tipo collettivistico, ma già abbraccia una visione individualistica rispetto all’agire del singolo. La vita comunitaria è in crisi e il teatro ne capta la fragilità.
Nessun dio accompagna Aiace. Un eroe umano che, nella guerra, vede quello che c’è realmente da vedere. La viltà, il tradimento, l’avidità, la paura dell’amico lo hanno contaminato. Le maschere dell’orrore sono mosche nere che affilano le unghie sul corno di bue. Aiace è un reduce, nessun dio lo aiuta. Le voci si amplificano dentro di lui, l’ingiustizia subita s’ingigantisce, ma non può farsi indietro, è incapace di desiderare il male degli altri. Ma le mosche ronzano sempre più insistenti, poi un’improvvisa calma e tranquillità, finalmente esce, saluta la moglie. S’incammina verso il fiume, va a lavare la grande spada dai grumi della guerra. Col suo sangue.
Agamennone
con Emanuele Vezzoli
La guerra di Troia è finita, gli Achei ritornano in Grecia. In questi dieci anni ad Argo, regno dell’assente Agamennone, la regina Clitemnestra ha intessuto una relazione con Egisto e maturato un odio sempre più profondo per il marito, responsabile della morte della figlia Ifigenia, sacrificata dal padre in cambio di venti favorevoli alle navi per salpare alla volta di Troia.
L’arrivo di Agamennone viene celebrato con sfarzo e opulenza dalla regina, il re accolto con parole seducenti dalla moglie è invitato al piacere di un caldo bagno. Lì sarà il teatro della vendetta di Clitemnestra, che a colpi di scure uccide il sovrano.
Agamennone è un predestinato, deve espiare la sua colpa e quella del padre Atreo, assassino dei figli del fratello Tieste, al quale vengono servite in pasto le carni dei bambini morti. Eschilo riprende il tema soloniano della giustizia che presto o tardi si abbatte sul colpevole e l’Agamennone, prima parte dell’Orestea, la trilogia dedicata agli Atridi, con cui l’autore vinse le Grandi Dionisie nel 458 a. C., ne è un esempio fulgido.
Palazzo di Micene. Clitemnestra ha predisposto l’assassinio del marito. Agamennone arriva. Chiede un bagno caldo. L’acqua è già pronta. Il re parla alla moglie. Da fuori, ovazioni e tumulto generale. Si dividono il bottino. Il re racconta. Cassandra urla sulla scala di marmo. Le figlie vengono mandate nelle loro stanze. Il re ricorda. L’acqua del bagno si sta freddando. Il re “vede” quello che è accaduto nei dieci anni di guerra e anche quello che accadrà quando avrà varcato la porta del bagno. Agamennone permette infine a Clitemnestra di accompagnarlo. S’incammina verso la fine.
Oreste
con Massimiliano Sbarsi
Oreste, figlio del re Agamennone e di Clitemnestra, fratello di Ifigenia, Elettra e Crisòtemi, è destinato a vendicare il padre, ucciso dalla moglie e dell’amante. Glielo svela l’oracolo di Delfi, glielo chiede la sorella Elettra. Il giovane era stato allontanato da Argo ancora in fasce per evitare di essere ucciso e divenuto adulto torna alla città natale per compiere il suo destino: assassinare la madre e Egisto a colpi d’ascia. Il matricidio però scatena la furia delle Erinni, divinità della vendetta contro i parenti, che torturano Oreste fino a farlo impazzire; egli fugge ad Atene dove Apollo, fautore dell’oracolo che lo aveva predestinato al matricidio, prende le sue difese. L’Aeropago, tribunale degli Dei, si divide sulla sua colpevolezza o innocenza e solo l’intervento di Atena farà pendere la bilancia verso la libertà di Oreste, mettendo così fine alla scia di sangue che ha funestato la stirpe degli Atridi. Le Erinni vengono trasformate in Eumenidi, divinità benevole; e Eumenidi è proprio il titolo del terzo capitolo dell’Orestea di Euripide, unica trilogia del teatro antico arrivata intatta fino a noi.
Oreste in compagnia dell’inseparabile Pilade, è fermo alle porte della città, rientrato dall’esilio. E’ un giovane afflitto da un arcano destino a cui vuole ribellarsi, sentendosi ormai estraneo alla cupa faida famigliare che lo vincola. Il destino di Oreste è la scissione interiore, la lacerazione tra il volere e il dovere, tra il passato e il futuro, tra la volontà degli altri e la sua: un dissidio che egli incarna e porta nel corpo, con le gambe aperte in un passo, attratte da forze opposte, che lo squarciano. Oreste è un ragazzo del presente, di quella Quarta Dimensione a cui Ritsos ha dedicato un’intera opera: non vuole ipotecare il suo futuro e rifiuta le sabbie mobili del mito nelle quali è immersa la sorella Elettra che ulula da anni il suo dolore e invoca vendetta. Scisso, deve esplorare il suo domani, scegliere di agire, svelare, conoscere, per trovare la libertà. Così, dopo una notte di ribellione e di rimpianto, Oreste accetta la sua ineluttabile sorte, ma agirà per sua scelta, per sua consapevolezza, senza più un dio a guidare la sua mano.
Delfi
con Nanni Tormen
Delfi è una città della Focide considerata in antichità l’ombelico del mondo, oracolo ufficiale della grecità, sede della Pizia, sacerdotessa di Apollo, che qui vaticinava. Nell’incipit delle Eumenidi eschilee, la Pizia racconta l’origine del mito di Delfi:
“Prima tra gli dei,
con questa invocazione onoro Gea, iniziatrice di profezie.
Poi Temi, che per seconda, come tramandano,
sedette su questo seggio profetico, su cui si era seduta la madre.
Per terza vi salì, con il consenso di Temi
e senza che alcuno esercitasse violenza su di lei,
un‘altra Titanide Febe, figlia di Terra, e Costei lo trasmise
come dono natale a Febo, che da Lei prese nome. Ed Egli,
lasciato il lago e la rupe di Delo, approdò alle coste di Pallade, passaggio di navi,
giunse a questa terra e alla dimora del Parnaso.
Lo scortarono, facendogli strada con grande venerazione, i figli di Efesto
Civilizzando una terra altrimenti selvaggia. E quando giunse
gli rese onore supremo il popolo di Delfo,
sovrano di questa contrada, che ne regge il timone. E Zeus,
ispirandogli nel petto l’arte profetica lo insediò su questo trono,
come quarto vaticinante.”
Due guide archeologiche, custodi degli scavi di Delfi, si trovano uno accanto all’altro dopo un’estenuante giornata di lavoro: uno anziano, l’altro giovane, osservano la folla di turisti lasciare il sito, seduti sulle pietre scaldate dal sole della lunga giornata estiva, in attesa che cali il fresco. E’ questa l’occasione per Ritsos di far parlare chi spesso rimane inascoltato: nella quiete delle rovine al tramonto, davanti alla bellezza di un leggendario passato, le statue, le pietre, i resti degli edifici, liberi dal mortificante sguardo turistico, si lasciano abbracciare dallo sguardo della guida più anziana, che si fa tramite del grido silenzioso dell’intraducibile.