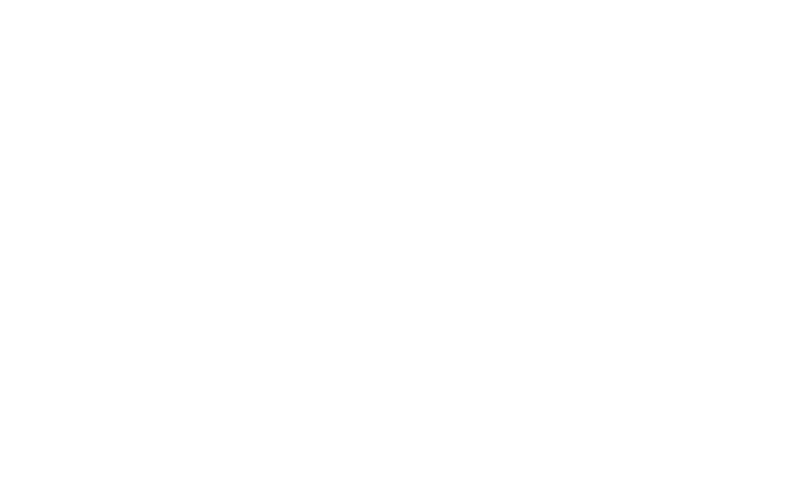foto: Giovanni Ferraguti
di ANTONIO MASCOLO
La storia di una vita, dove giocano a nascondino realtà e recite. La storia di una delle grandi “invenzioni della città”. È molto lungo, ci sono tante cose. Meravigliosi e intensi quegli anni… Se amate il teatro poi…Bozza di una mancanza. Nella foto (ingranditela) il “Gargantua& Pantagruel” di Rabelais recitato al Regio con platea completamente coperta per diventare un mondo di palcoscenico.
******
Non sapevo nemmeno cosa fosse, il teatro. Forse il sudore, le scalate degli alberi a prendere i gelsi bianchi vicino all’attuale aeroporto.
Forse le corse tra i campi di una vita zotica, come quando andai alla sacra Lavanda dei piedi in Santa Maria della Pace a farmi lavare, appunto, le zampe tutte sporche di fango per la corsa e il giocare a pallone; e quello sguardo terribile di rimprovero e stupore del parroco-lavatore divenne per me indimenticabile interpretazione, scenico, convincente dramma.
Un qualche profumo di teatro, da piccolo, saliva dalle scale, dai Balestrieri, quelli del primo piano, lui operaio alla Luciani. Mario e la Teresa, appassionati di opera lirica che tutto il giorno ascoltavano e confrontavano acuti verdiani sui dischi per poi andare una volta l’anno al Regio ad ascoltare gli artisti in carne ed ossa. E ritornavano tifosi sempre, ma un poco delusi, nessuno raggiungeva la perfezione del grammofono.
Forse, di teatro, qualche sfilata di Carnevale, qualche burattinata da Zaffardi all’Annunciata o dai Ferrari. E, tanti anni dopo, firmare anche una presuntuosissima – ma meravigliosa almeno per me – regia al Regio con Le troiane di Euripide interpretato da una classe di bellissime studentesse del Romagnosi.
Poi come una magìa di scena, per una vita ci sono sempre stato, di sguincio. Al Regio era la poltrona 84, in platea. Seduto lì a prendere appunti al buio, a guardare, tentare di conoscere e di capire.
Per la cronaca, primo spettacolo recensito – con la sigla “vice” – “Dio Kurt” di Moravia con Gigi Proietti, non un granchè, mi sembrò straordinario.
Quella poltrona prima di me fu occupata da Nicola Pressburger e poi da Pieparide Tedeschi. In quegli anni l’università di Parma aveva anche straordinari corsi di storia del teatro gestiti dal prof. Cesare Molinari e da Fernando Mastropasqua.
La mia dieta teatrale superava anche 250 spettacoli l’anno, festivaloni e festivalini compresi (immancabile per anni una pagina al giorno dal Festival di Spoleto che seguivo per un’agenzia di tanti giornali locali di nome Aga, grazie ad un’altra intuizione di Baldassarre Molossi).
Tutto è cominciato in un luogo bruttarello anche allora. In vicolo Grossardi, dove agiva il CUT (Centro universitario teatrale). C’era Giorgio Belledi, c’era “Lallo” Ilari, che poi, in un gesto di altruismo teatrale lungo una vita, avrebbe recitato con tutte ma proprio tutte le nascenti compagnie di Parma. Una leggenda, un monumento vivente.
Poi, credo, una cosa che non capii molto ma mi rapì: “Orazi e Curiazi” a torso nudo nel quartiere Montanara. Che potenza, che umiltà con quella parola, non bellissima che era decentramento.
E afferrai la lezione base che il gruppo, poi Collettivo poi Teatro Due poi Ensemble, poi Fondazione, avrebbe sempre perseguito. La base del tutto. Il teatro sono gli altri; oh, certo, tu puoi fare anche un monologo ma, se non ci sono gli altri, sei solo e soltanto uno specchio vuoto.

Nuovo Raccoglitore, 5 ottobre 1983
Facevo il mio ingresso all’Osteria del sogno, dove la notte era il giorno, le “ciucche” assai frequenti, ubriacature interminabili, come le discussioni, tenere e spietate. Pietanze marxiane, l’eterna lotta tra etica ed estetica, la differenza tra teatralità e spettacolarità. In quelle prime notti acerbe capii che il teatro è la neve (magari la puoi fare con pezzettini di carta) che ogni volta stupisce e si scioglie. Solo in apparenza è superflua o persa, magicamente torna la sera dopo.
Il teatro è sogno. Eravamo giovani con la coscienza di essere nati vecchi, con tutto quel cercare saggezza, spaccare i capelli in quattro, dubbi, “topi nell’anima”. Una sfida continua, la dialettica dell’essere bravini, meglio bravi, cercando di essere i migliori, per andare avanti, per imporsi a un Potere che non faceva sconti. Abitavamo la battaglia.
La gran molla della curiosità, le letture smodate, la fame di vita, i resoconti dei viaggi, gli amori e le passioni, le melanconie. Volevamo cambiare il mondo, al minimo rotolarci dentro di lui.
Eravamo viandanti, che poi non è molto lontano dai comici, dagli zanni, che uscivano dalla storia del teatro che ormai divoravo per prepararmi a chissà cosa.
Il primo simbolo del Collettivo fu un triangolo. Pensavo: attori, pubblico, teatro. Ma due, uno sopra l’altro, di punta, richiamavano una clessidra: il Mulino di Amleto, il tempo che scorre. Perché puoi fare quello che vuoi, ma Shakespeare è sempre lì. Due triangoli: il futile e l’utile, la teoria e la pratica, i sogni e la realtà, il passato e il futuro, la saggezza e la follia.
Da subito, il gruppo ha avuto una caratteristica unica: essere locale e globale. Battevano il territorio e sognavano il pianeta. La scena era mondo, rapporti internazionali, amici lontani, esperienze vicine. Il vaso comunicante era stato sempre il Festival del teatro universitario (quello ad esempio di Jean Jacques Lebel, che portò tutto il pubblico seduto al Regio, in un happening in giro per la città), le tournèe e Giorgio Gennari che diventava, via-via, l’unico inimitabile ministro degli esteri di una compagnia teatrale italiana.
Hanno portato a Parma l’Europa prima della Ue. Hanno lottato come degli sfrattati veri ed affamati, per avere una casa, hanno lottato con grande lungimiranza sapendo che lo spazio modifica l’estetica, le produzioni.
Quinto Stato, di necessità.

Gargantua e Pantagruel, foto di Giovanni Ferraguti
Hanno lottato per la produzione e non solo per l’ospitalità, hanno lottato per tenere sotto il cielo parmigiano i saperi dei tecnici, per i vasi comunicanti magari sconosciuti che fanno fluire l’andare in scena, pensando soprattutto a quelli che sarebbero venuti dopo.
Hanno lottato, unici in Italia, per avere un critico residente, che partecipasse con loro alle prove, agli sbagli, ai sudori alle fatiche per comprendere ogni sfumatura artistica, poetica. Perché il teatro è un poco come la maratona, bellissima, estenuante, ma forse i mesi più belli sono quelli passati a preparare, a spostare il limite. Ed è stato un privilegio guardare i loro … allenamenti.
Ripropongo alcune righe che ho scritto sul Raccoglitore il 5 ottobre 1983. “La storia della tribù del Collettivo è un caso strano. Conosciuti e stimati più all’estero e in Italia che in questa nostra Parma … considerati qui in città, un poco dilettanteschi e osannati come pietre miliari in Inghilterra, Germania, Olanda ecc …. Giudicati spesso con preconcetti ed ostilità sono concreti, intelligenti al punto che hanno fatto un Macbeth con le stesse motivazioni artistiche di Carmelo Bene. Solo con due anni di anticipo”.
La “banda di via Basetti”, l’Opificio delle teste dure, è stata una delle piccole grandi rivoluzioni positive in questa città strana che sa anche eccellere – spesso e volentieri – in scandali, crack e pasticci. Compagni che sbagliano ma che ne hanno anche azzeccate alcune. Come quando si sono imposti fisicamente per occupare tutti i locali dell’Ex Enal per troppo tempo vissuta in una non troppa decorosa mezzadria con l’Arci dell’adorabile Rosselli.
“San Gennaro, Sant’Ilario liberaci dai vigili, dall’Arci, da Radio Bella” scriveva sulla Gazzetta il sulfureo Walter Le Moli. E l’altra anima, Gigi Dall’Aglio, “Una casa, sì una casa, dove puoi anche portare la macchina in camera da letto”.
Oh, certo, non erano tutte rose e fiori. Chi faceva parte del gruppo era affilato e tagliente come una lama, immaginate gli scontri veri quelli che il pubblico non ha mai visto in scena. Lo scaravoltarsi l’un l’altro. Ma l’atomica non è mai esplosa o meglio il “fungo” non si è mai visto chiaramente all’esterno …
Per molti giovani è stata una sorta di improvvisata Harvard umanistica. Una serie di obbligate ripetizioni, di inviti ad allargare lo sguardo. Tanti autori, tanti occhi, tanti uncini per agganciare e crearsi un loro pubblico. Esclusivo come il calcare quel palcoscenico.
Penso di avere visto tutte le loro produzioni.
Compagni di una sera, compagni di una vita.
Letteralmente, con questi “Enfants de la scéne” figli, fratelli, padri, madri, sorelle di sè stessi e del teatro, in una famiglia strana, affascinante, densa come i grappoli d’uva nel torchio.
Densa come i grappoli d’uva nel torchio, poi, la banda si è creata il proprio pubblico, stagione dopo stagione.
Hanno sempre “servito la polenta su un piatto d’argento”, la base popolare, l’anima del teatro, confezionata poi come fosse qualcosa di lusso per le sere di festa.
Il segreto è chi si sono presi cura di noi, negli anni ci hanno cambiato gli occhi, la poetica dello sguardo. Come una romantica officina – prima un garage, poi, tutti tirati a lucido, in più saloni – ci hanno sempre riparato. Hanno messo nei nostri ingranaggi, fili d’oro in uno stranissimo, forsanche improbabile, kintsugi padano.
Sono andati al fronte per noi, a combattere, a fare domande, a mettere se stessi nelle piaghe del contemporaneo, dell’umano e ci hanno chiamato o sono tornati indietro a raccontare le contraddizioni, le paure, le speranze, le fratture. L’officina del lavoro-lavoro-lavoro, del dubbio-dubbio-dubbio. E disordinati, sempre, come è la ricerca della vita, soprattutto quando ti imponi di usare il Noi.
Sono stati 50 anni vissuti in una galleria del vento, sempre più potente: capelli e cuori scarmigliati. Impossibile, anche ingiusto, forse sbattere oltre mezzo secolo di vita in poche righe. Ma anche questo è un poco l’essenza del teatro che maneggia secoli, grandi drammi, timori e tremori, abissi, come se tutto fosse semplice e naturale. Ogni esperienza è stato un cerchio concentrico che si allargava sulla vita, sulle esperienze per poi tornare indietro arricchito nel racconto, nelle discussioni, nelle condivisioni. Il teatro è l’essenza del viaggio, ecco alcune istantanee.
Ecco allora, l’Orso che si sveglia. Che bello nelle cantine e nel bar del primo Due, scrollarsi di dosso le fatiche della notte del TfP (Teatro festival Parma), passata a preparare cataloghi, provare spettacoli, montare scene, incontrare gente, compresi i fotografi che mandava da mezzo mondo Alberto Nodolini per “Vogue” (che gran mostra, che gran libro sarebbero quegli sguardi). Che serate, che follie, che risate, come quando uno dei più affermati clic del mondo, fotografò sul palcoscenico il critico teatrale e prof Ugo Volli: magrissimo, tutto nudo, solo con la macchina da scrivere davanti ai genitali.
E la follia di quel viaggio a Londonderry, nell’Ulster in fiamme, per vedere uno spettacolo sul collaborazionismo da invitare, eventualmente, al Teatro Festival. E ritrovarsi unico passeggero su un aereo da 8 posti e un solo pilota, vuota la seggiola e la cloche del secondo. Una nebbia impenetrabile, le luci dell’aeroporto che si accendono solo il tempo per fare atterrare il velivolo. Soldati in assetto di guerra che ti caricano su un autoblindo e ti portano in un albergo dove sono più buchi e le bruciature sui muri delle camere dell’hotel. Notti al sapore di Bushmills e giorni da brividi, tra cavalli di frisia, disperazione, gioventù bruciate da entrambe le parti, paure di attentati…
“Ma dove cazzo sono i canguri?” ripetevamo anche noi quella frase famosa di Thelonious Monk. Eravamo, in Australia, tra un incontro con quelli di “Azzurra” Cino Ricci, Pelaschier e gli altri, un drink nei giardini dell’ambasciata italiana e ascoltare gli psichiatri con molti agganci a Parma che lavoravano – tanto – sul disagio degli aborigeni, inglobati prima dall’alcool che dalle città. Fusi avvelenati, affascinanti e un poco folli come quel portare “Macbeth” a Perth.
E quando a Cracovia, dopo le passeggiate col mitico Carrozzino gli incontri con Olga e gli attori dello “Stu”, dovetti recitare , per una improvvisa defezione. Ci fu davvero da ridere, dietro e davanti le quinte. E credo fosse veramente un record, anche per un critico teatrale come si diceva allora “militante”.
Eravamo in una pasticceria a Rotschild Road per un’intervista con lo scrittore Abraham B. Yehoshua per la prima rappresentazione a Tel Aviv e in Israele de “L’istruttoria” di Peter Weiss un vero evento, tosto, problematico, pieno di sfaccettature. E il grande scrittore ci confessò, in quella pasticceria color fantasia, il suo giudizio altamente positivo sullo spettacolo “Qui non c’è pietismo né catarsi, ciascuno è attaccato al muro nero delle proprie responsabilità”. Dodici anni fa e fu quella l’unica volta che lo spettacolo venne recitato tutto in maniera frontale, nei suoi 36 anni di rappresentazione.
O a Parigi col candido, elegante “Marat Sade” la musica delle Quattro stagioni di Vivaldi a far volare con leggerezza la crudeltà, a conquistare gli snob. Si è vero all’estero, la “meglio gioventù” parmigiana ha dato il meglio, era come se giocasse sempre in casa.
Guarda caso da lì, da lontano è venuto proprio “il più parmigiano e collettivo degli stranieri” il regista Bogdan Jerkovic al quale si deve una meravigliosa follia che ha fatto fare un salto di qualità del gruppo anche nei confronti della città. “Gargantua e Pantagruel” di Rabelais.
L’assalto al “teatro borghese” dei reietti della scena avvenne con una grande e faticosissima magia. Via tutte le sedie dalla platea, tutto palcoscenico in legno all’altezza del davanzale dei primi palchi dall’ingresso alla scena, grazie anche al lavoro dei macchinisti e tecnici del Regio.
Un sogno, un grande spettacolo dell’uomo dell’Est che colpì al cuore la sua Parma.
Oppure i resoconti di spettacoli straordinari, discussi sulle scale di via Basetti. Per Grotowsky chiusi a chiave per sei ore dentro uno stabile all’isola di San Giorgio, o la 24 ore di Bob Wilson sempre a Venezia con noi critici italiani a far da staffetta…. ai tavoli del ristorante della Fenice.
Dalle Orestiadi di Ronconi ,alle regie di Ariane Mnouchkine , a Peter Brook, ad Eugenio Barba che fece uno spaventevole teatro nel buio assoluto del Ridotto del Regio con bastonate che ti passavano nell’oscurità ad un centimetro dal corpo; allo scambiare due tiri a pallone magici con Carmelo Bene davanti alla pizzeria Fontana, alle pizze con Roberto Benigni, ai dopo teatro da Michele Vitali Mazza, le serate con quelli del Teatro dell’Elfo di Elio de Capitani e Gabriele Salvatores, l’irruzione al Due di Battiato, la leggenda della danza giapponese Kazhuo Ono, il mito Pina Bausch, Nekrosius ; il Festival di Polverigi straordinario inno alla fantasia creato da uno spettatore eccellente del Due, il neurologo Memo Mancia, tantissimi altri sogni realizzati.
No, no, non è un semplice elenco, è l’indice di una fame di vita, sono alcuni fili di quella matassa che ci avvolgeva, ricchissima, meravigliosa, quegli anni generatori di esperienze, contaminatori di idee… Le Briciole, Lenz…
Qui si narra di un gruppo che ha fatto teatro per tutta l’esistenza, son diventati urlanti, ciechi , muti paralizzati, si sono ringiovaniti invecchiati, pur di comunicare ,indossare i panni intimamente nostri sulla scena .”A che punto è la notte?” domandava Georg Buchner (e sempre a proposito di Buchner “avevamo sognato tutto diverso tra i mirti e gli oleandri” loro hanno sognato proprio tutto molto giusto), loro quella notte l’hanno vissuta e attraversata con noi. Il loro più grande spettacolo è reale dove si racconta di un gruppo di moderni guitti che hanno costruito una casa di nome teatro, un’osteria del sogno dove hanno incuriosito e nutrito alcune generazioni. Un luogo familiare, dell’anima. Un brandello di rivoluzione al potere, un virus positivo, pensante.
Ed eccoli, come nei titoli di coda, nel sipario che si apre e si chiude unendo, eliminando le differenze di ruolo, in fila per gli applausi…
Tania Rocchetta, la potenza del silenzio, la nostra Marianne, generazioni innamorate di lei, del suo rigore, della sua credibilità. La più grande attrice parmigiana dal Dopoguerra.
Giorgio Gennari, il grande viaggiatore, scrittore, gran “tacabottòn”, volto scolpito nella quercia dei valori, montanaro magico e mai domo che si rifugiava nel nostro Appennino a due passi, non a caso, dal Mago Zurlì.
Gigi Dall’Aglio, è teatro sempre anche quando non lo esercita o muove un dito solo. Cultura, passione, curiosità, antropologia, tecnica si amplificano in lui e nei suoi insegnamenti.
Walter Le Moli, politico, visionario, misto di dolcezze e durezza, la passione per i tempi e per la musica gli ha dato una ulteriore vita e lettura della realtà.
Paolo Bocelli, operaista con la o maiuscola, grande conoscitore di cimiteri e tradizioni, la sua “erre” altera lo ha portato ad abitare chiunque e ovunque, anche l’impossibile.
Marcello Vazzoler, ha portato il sapore e la complessità del mare, della gente concreta dei porti, la ruvida delicatezza che viene da lontano.
Roberto Abbati, l’irruenza dolce, la testardaggine produttiva, una furia inarrestabile verso il paradiso.
Laura Cleri, etrusca, profonda, solida, sensibile, occhi senza età, coraggiosa nelle scelte artistiche, sa essere in scena “sporca” e perfetta.
Cristina Cattellani, che sa cambiare volti ed anima scenica come poche. Da del tu alle pause e agli sguardi.
Paola Donati, s’è fatta storia, complessità, decisione, autorevolezza, tutt’uno con la crescita e i problemi del gruppo e della struttura.
Eppoi la Nicetta, Pietro, la “Astri… del ciel”. Francesca, Francesca 2 e Francesco, Annetta, Claudio il re delle luci e l’amica Lucia tra le ultime arrivate. E le seconde generazioni, figlie d’arte, Lucrezia Le Moli e Isadora Borelli (figlia di Paola Donati).
Sono partiti tutti dalle loro imperfezioni, ne hanno preso coscienza, si sono dati dignità e così anche le sconfitte, gli spettacoli non riusciti, son diventate vittorie. Hanno cercato gli smarrimenti ma non si sono smarriti. Hanno fatto qualcosa di irripetibile, di davvero unico. Sembrando immobili, caduchi e precari sulle scene sono diventati forti ed hanno puntato all’eternità, una delle facce del teatro. Il viaggio continuerà.
Il teatro è la neve (magari la puoi fare solo con un pezzo di carta) che ogni volta stupisce e si scioglie. Come mi hanno svelato Tania e Laura, un giorno, in una scenografia de l’Istruttoria, quella dei camerini dove gli attori si specchiano, prima che il pubblico entri sulle gradinate, dall’84, c’è attaccata anche una mia piccola foto tessera, di carta . Un fiocco di neve….
Compagni per una sera, compagni per una vita.
PS 1: Questa bozza va intesa anche come una dolce recensione di “Principi e prigionieri”, toccante documentario di Lucrezia Le Moli e Amedeo Guarnieri, prematuramente scomparso.
PS 2: Citazioni ritrovate.
“Noi abbiamo sognato il mondo. Lo abbiamo sognato, resistente, misterioso, visibile, onnipresente, nello spazio e fisso nel tempo; ma abbiamo consentito nella sua architettura tenui ed eterni interstizi di assurdi per sapere che è falso” (Borges).
“Stanno giocando a un gioco. Stanno giocando a non giocare ad un gioco. Se mostro loro che li vedo giocare, infrangerò le regole emi puniranno: Devo giocare alloro gioco, di non vedere che vedo il gioco” (Laing).
“Sono sempre d’avviso che Shakespeare fosse una cooperativa. Che per le buffonate si servisse di cerretani pari a lui nel genio ma incuranti di tutto fuorchè dei soldi. Non può ingoiare troppo la sopravvivenza. A volte digerisce un plotone, tale altra distilla poche sillabe e butta un monumento nel secchio dei rifiuti, Produce come i funghi, puoi trovarne parecchi tutt’insieme, poi resti a mani vuote per un giorno intero o per un anno o per un secolo. Dipende… (Montale, Quaderno dei quattro anni”).
“La vita è un guizzo di cazzo” (Shakespeare).
“Che guaio una vita senza guai” (Il verdetto, Sidney Lumet).
“Chi sono? Qualcuno che sogna” (Il balcone, Jean Genet ).
“Ho provato semplicemente una improvvisa voglia di impossibile” (Caligola, di Albert Camus).