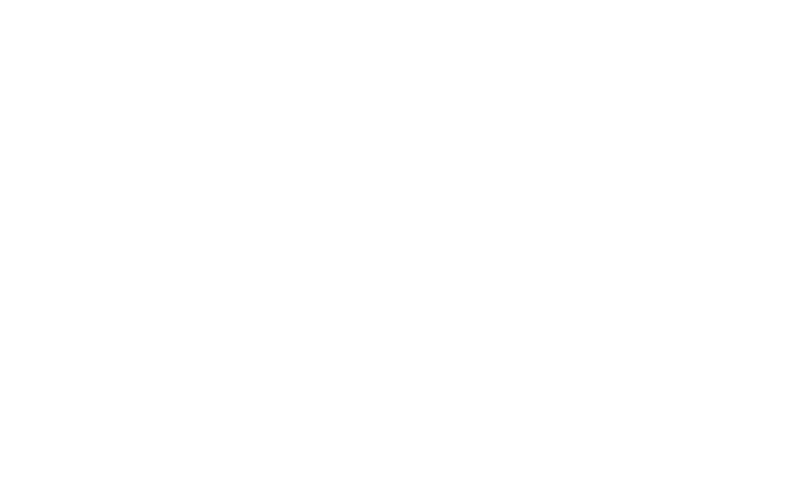Viviamo in un mondo popolato di schermi. Un mondo in cui tutto, dall’azione più insignificante all’evento più epocale, sembra succedere al di là di un sottile ma confortante strato di vetro attraverso il quale tocchiamo, spostiamo e quindi modifichiamo la realtà. Una realtà che ci piace chiamare liquida, ma che a ben guardare diventa sempre più vischiosa. Sempre più spesso i meccanismi di questo apparato s’inceppano, le tubature s’intasano, e la imprescindibile libertà che ormai diamo per scontata sembra scricchiolare. Poco male: anche i disastri, le guerre, i massacri più efferati che nel mondo succedono e continuano a succedere si palesano già muniti di pulsante per la condivisione, pronti a rimbalzare di tasca in tasca. Come società, siamo molto più abituati agli schizzi di sangue, ma siamo anche sicuri che non ci sporcheranno. Di fronte a un urlo di dolore, al più dobbiamo soltanto abbassare il volume, e scegliere a chi dare ragione. Guai a noi se non lo facciamo. Il mondo in cui siamo immersi è, a guardarlo, un composto di popolazione assuefatta all’inumano, ma contemporaneamente attentissima al realismo.
La prospettiva sembra quella di un moderno Panopticon, la stupenda prigione ideale che Jeremy Bentham aveva inventato per portare il controllo sull’individuo (sul condannato) al massimo livello di ergonomia, e quindi di crudeltà. Ma in questo caso si tratta di un Panopticon invertito nei suoi elementi fondamentali. Una prigione senza sbarre in cui la massa, degenerazione del gruppo, è il sorvegliante e, il singolo, il sorvegliato. In questo sistema inclusivo e opprimente la massa fluida sceglie il suo centro e lo avvolge, di volta in volta lo esamina, lo aggira, e infine lo giudica, facendosi forza sulla molteplicità del punto di vista ed eliminando le fluttuazioni non gradite attraverso la leva della libertà di opinione. “Chi controlla i controllori”, ci si chiedeva un tempo, mentre oggi nuove forme di violenza invertono lo specchio e fanno in modo che il controllo sia generalizzato e, nel peggiore dei casi, involontario. Il reato più grande, in un’ottica che sembra nuova, ma che di fatto uccide il diverso come è sempre stato durante i periodi di appiattimento umano, è non avere un’opinione. Non prendere parte, non giocare alla grande giostra della società che tutto vede e tutto valuta, e si salvi chi può.
Come ha avuto origine questo virus? Cosa ha reso il cosiddetto “mondo libero” un luogo in cui meccanismi di autolimitazione e di castrazione del prossimo sono il pane quotidiano? Ciò che ha reso la violenza una componente usuale del camminare nel mondo è da ricercarsi in un potere esterno a cui si acconsente, o piuttosto a una tendenza alla coercizione che si autogenera nelle strutture sociali, dalla famiglia alla scuola, dal governo al Mondo Così Com’è e che esercita pressione fino al collasso dei tessuti e finalmente alla deflagrazione?
Di qui il senso di mettere in scena La Prigione, un testo (o per dirla con Pierre Biner, “a malapena una pièce) da cui non può nascere solo uno “spettacolo”. Perché? Perché contiene istanze immediate, non mediate, automatiche, e che riguardano l’accadimento in se stesso. The brig, questo è il titolo originale, inteso come il ponte di una nave di dannati, un brigantino, un novello girone dell’inferno. E l’inferno non si può raccontare: se ne può soltanto fare esperienza. Una baracca adibita a prigione, un gruppo di soldati che hanno commesso delle infrazioni al codice, dei carcerieri che li sorvegliano mentre scontano la pena. Una reiterazione ossessiva di codici, di gesti che manifestano la rigidità di un sistema coercitivo. Sistema, a sua volta, che se da una parte può funzionare solo così, dall’altra manifesta la sua vacuità attraverso il suo ripiegarsi su se stesso fino all’annullamento e al ricambio delle sue componenti. Non è una sorpresa che alla sua prima rappresentazione, per mano del Living Theatre, The brig sia stato visto dagli spettatori attraverso le maglie di una rete metallica che li divideva dall’azione scenica. E non è una sorpresa che forse oggi la necessità sia quella di infrangere quel vetro, quella pellicola di densa indifferenza che fa rimanere comodamente seduti e definire un’operazione del genere “simbolica”. Perché forse è di simboli che si sta parlando, ma il rapporto causa-effetto cambia, eccome: il realismo di cui si cerca spasmodicamente la targhetta, il “made in PRC” è qui, è ora, è tutto fisico e non raccontato, e rappresenta senza simboleggiare. Dove ci porta? In nessun luogo specifico, niente che possa essere comodamente fatto uscire dalla porta o dalla finestra, nient’altro che un automatismo che ci è fin troppo famigliare. Anche nelle scene di tortura? Anche nelle scene di tortura. Senza far caso al fatto che milioni di morti scorrono davanti agli occhi tutti i giorni e che noi, pur avvicinando lo sguardo, non facciamo altro che allontanarci da luoghi che sono geograficamente talmente vicini che ci farebbero cadere nel terrore se solo ce ne rendessimo conto. Nel momento in cui si abbandona il realismo e si rappresenta la realtà, una realtà ridotta a una giornata di detenzione in un carcere che al contrario del Panopticon non ha nulla di ideale, ci si accorge che è molto difficile essere davvero partecipi senza percepire che il torturatore e il torturato non sono altro che uomo e uomo. Esistono e quindi si torturano, in una vicissitudine di ruoli non tanto scelti quanto imposti in virtù della loro predicata necessità. Ed è difficile condividere quello spazio senza rendersi conto che non serve essere in un carcere per scoprirsi torturatore o torturato, carnefice o spettatore inerte. Rotto il vetro, però, mentre si respira la stessa aria, accade l’esperienza. Nella difficoltà di riconoscere cosa c’è di ancora possibile davanti all’abbrutimento si può forse cercare una conoscenza non più schiava della tecnica, non più schiava della sfinente ricerca della risposta, e finalmente volta a quello che il teatro è veramente: la creazione di domande. E se l’esperienza è estrema, la necessità lo sarà di conseguenza, rendendo ciò che di umano c’è nell’uomo meno distante e meno nascosto dietro le prigioni, siano esse di carta o di silicio. Perché l’epoca della complessità è arrivata, e non ce ne siamo neanche accorti. La crudeltà nell’era della complessità, nell’era dei giochi, dell’esperienza virtuale, del sentito dire, e del virale, va esperita senza fili spinati e senza schermi, insomma senza alibi. Possiamo farlo.