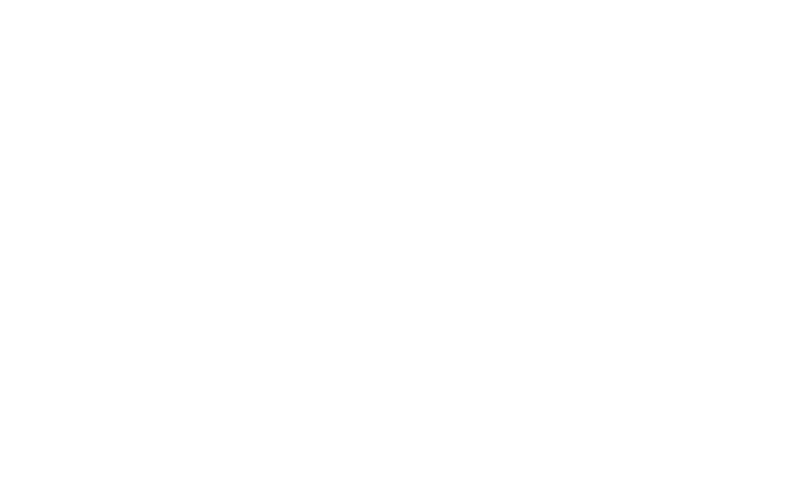ph. Mauricio Cáceres
Mezz’ore d’autore – le interviste
Rafael Spregelburd
Il progetto Mezz’ore d’autore si propone come scintilla per innescare una riflessione sulla drammaturgia contemporanea. La messa in scena dei testi selezionati è accompagnata da approfondimenti, interviste, dibattiti aperti al pubblico incentrati sulle inquietudini della scrittura per il teatro, sulle possibilità offerte dal panorama politico e culturale di vari paesi nel mondo, sulla scelta delle tematiche da affrontare e sui linguaggi più efficaci oggi per veicolare significati attraverso un medium che è fra i più antichi della storia umana. Abbiamo formulato alcuni nuclei tematici e li abbiamo sottoposti all’attenzione di quattro autori teatrali, per condividere insieme a loro i cardini salienti delle riflessioni in atto, con l’intenzione di contribuire a disegnare una mappa della nuova drammaturgia in Europa e nel mondo.
Qual è lo stato dell’arte della nuova drammaturgia oggi?
Caspita, sono molte parole: stato, arte, nuova, contemporanea. Sarebbe un sogno poter affermare che il teatro puro che amiamo andare a vedere, il teatro che – nella contemporaneità – sembra essersi liberato in qualche modo del dovere di parlare unicamente e in prima istanza di ciò che è importante (o meglio, di aggiornare la lista dei grandi temi che la società impone al teatro tra i suoi obblighi), sia sempre una forma di espressione “artistica”. Però dobbiamo ammettere che questo non succede sempre, o quantomeno che per ora il concetto di arte, (così come quello di cultura, cerimonia, intrattenimento, spettacolo, pittura o artigianato), non è sempre ciò che promuove l’evoluzione tecnica della drammaturgia e del teatro.
Viviamo in un’epoca aperta, dove ogni artista crede di esplorare una nuova definizione di ciò che è arte, ma che in realtà è copia dell’arte che ci ha preceduto. La Storia è a favore di questa presunzione: abbiamo una visione d’insieme sul passato dell’arte, siamo in grado di spiegare perché sono sopravvissuti i classici e sono invece spariti gli imitatori o gli intrattenitori dei vari periodi culturali del passato. E senza dubbio, non siamo in condizione di poter valutare oggettivamente le qualità “artistiche” di un’opera d’arte contemporanea. A patto di accettare che sia arte solo ciò che è legato ad una sperimentazione, ad un rischio e allo svelamento di qualcosa di celato, e non alla mera produzione di opere belle per il consumo massivo di una cultura che ha già definito in che maniera consumarle. Il vero artista sarebbe allora colui che rivela il senso a una parte di società a cui il senso era negato, a cui era invisibile. Questa modalità era abbastanza chiara nell’epoca delle avanguardie dell’inizio del ventesimo secolo, fenomeni graziosi e donchisciottiani, che adottavano le idee più strampalate per rivelare alla società i suoi aspetti più nascosti. Ma nell’era in cui tutto si vede, in cui tutto si pubblica, in cui siamo saturati dalle immagini, la modalità avanguardista sa di vecchio; pretendiamo risposte immediate e semplici per problemi profondi e complessi. Vogliamo riflettere, ma rimanendo entro i 6 minuti di una TED talk. Vogliamo grandi opere, ma gli autori contemporanei non possono scrivere per più di 4 personaggi. Pubblichiamo libri di filosofia, ma preferiamo leggere la realtà attraverso i meme sui cellulari. È triste però è ora di ammetterlo: non ci è toccato in sorte di vivere nel tempo più intelligente, né il più sensibile, nell’evoluzione della società. Gli artisti continuano a lottare per non cadere nel puro estetismo, quello che in altre epoche avrebbe fatto di loro dei veri e propri artisti. Questa definizione appare (insieme a molte altre) relativizzata.
Le nuove drammaturgie, quelle che definiamo contemporanee, sono molteplici e variopinte. Molte volte in esse troviamo rigurgiti di epoche anteriori; in altri casi, solo le tendenze del momento e opportunismo. Una lettura affrettata dei tratti del post-dramma non fa altro che accentuare questa confusione: il post-dramma non è necessariamente “più artistico del dramma” (soprattutto se è tendenza globale e successo di botteghino nei festival e nelle rassegne), né, d’altro canto, il dramma può continuare a sopravvivere senza modificare radicalmente il suo DNA man mano che le società ipercapitalistiche e – adesso – pandemiche esplorano i limiti delle sue regole interne.
Nel paese in cui lei vive, c’è attenzione alla nuova drammaturgia? Quale politica seguono i teatri?
C’è un enorme interesse che si traduce in aumento di pubblico; ma non nelle politiche culturali ufficiali rispetto ad un campo che – a dirla tutta – ha inserito l’Argentina all’interno della mappa del mondo teatrale. Il nostro è un teatro ibrido, ricco e meticcio. Con una grande voglia di dialogo con il pubblico (metamorfosi diretta o indiretta della realtà) e con la poesia (la costruzione di universi che non esistono a priori), una dualità che non si incontra facilmente in tutte le culture teatrali. Il nostro pubblico si è via via abituato ad un livello qualitativo abbastanza alto anche nelle ricerche più bizzarre. E questa è una cosa molto buona. Però non sono “i teatri” ad essere protagonisti di questo fenomeno. Bisogna riconoscere che le politiche culturali pubbliche sono molto varie e di solito stanno nella retroguardia rispetto a una scena così ricca e multiforme. Questo si può vedere con chiarezza analizzando i cartelloni dei pochissimi teatri pubblici che abbiamo (che rappresentano una piccolissima percentuale del teatro che si fa nel nostro paese). I teatri pubblici di Buenos Aires si contano sulle dita di una mano (non sono più di 5) al contrario delle sale indipendenti che sono circa 300. Questa asimmetria unica e inspiegabile fa sì che lo Stato utilizzi i suoi pochi spazi pubblici come una sorta di vetrina didattica, dove vengono mescolati classici attualizzati in modo da incontrare il favore del pubblico, teatro più serio affidato a volti televisivi e un piccolissimo spazio dedicato alla nuova drammaturgia per far vedere che sono interessati ai giovani; a loro sono riservate le sale più piccole e meno attrezzate dove si suppone andrà meno pubblico. Ci si chiede il perché, dato che questi stessi autori riempiono le sale dei circuiti alternativi e indipendenti. Perché, se i loro testi riempiono teatri molto più grossi a Barcellona, Parigi o Milano? Nessuno lo sa. Non ci sono politiche culturali durature che sostengano la formazione di questi autori, attori e registi che ottengono grande successo fuori dall’Argentina, soprattutto in Spagna, Germania, Austria, Francia, Italia e Belgio, o in altri paesi dell’America latina che hanno instaurato un forte legame con il fenomeno teatrale porteño come Cile, Colombia e Messico.
In altre parole, la politica culturale di sostegno agli artisti contemporanei è spesso quella dell’espulsione. Il riconoscimento deve essere ottenuto al di fuori del Paese per poi attirare l’attenzione di un pubblico più ampio nelle stanze del circuito indipendente argentino. Sono state delle eccezioni, poche, quelle di alcuni personaggi della cultura che hanno cercato di invertire questo fenomeno proponendo negli spazi pubblici le opere di quegli artisti che normalmente vedono più facile una prima al Piccolo di Milano o al Festival di Avignone che in una sala pubblica in Argentina. Una di queste sane eccezioni è stata la gestione del drammaturgo Alejandro Tantanian del Teatro Nacional Cervantes, ma quella primavera è durata poco (2017-2019): nessuna politica in questo Paese dura abbastanza a lungo da resistere di fronte ai continui cambiamenti. È stato più o meno dimostrato che al di là delle buone intenzioni personali di alcuni che fanno molto per fornire un quadro ragionevole, le istituzioni pubbliche, delinquenti e burocratiche, non sembrano essere progettate per accompagnare elegantemente e liberamente le esigenze di un Teatro d’Arte, serio e impegnato nelle regole del gioco della sua specificità. Non mi appartiene la presunzione di trovare colpevoli espliciti, mi sembra semplicemente che si tratti di un’incuria assai diffusa, di povertà di presupposti e di una burocrazia incancrenita nel cuore di diverse istituzioni che non permette di decollare.
Che ruolo può giocare la nuova drammaturgia nel ridare centralità al Teatro all’interno del dibattito pubblico?
Abbiamo altre possibilità? Possiamo presumere che un’opera scritta 400 anni fa abbia maggiori possibilità di innescare quel dibattito rispetto ad un’opera contemporanea? In questo caso le risposte sono diametralmente opposte secondo il Paese in cui ti trovi. Provengo da una cultura in cui il novantacinque per cento degli autori rappresentati è costituito da autori viventi, e capisco che si tratti di una situazione eccezionale. La vecchia Europa preferisce rigurgitare eternamente i suoi classici, condendoli con qualche novità, più o meno passeggera, più o meno futile, ma presupponendo sempre automaticamente che avrà più rilevanza per il dibattito culturale pubblico un testo classico rispetto ad un contemporaneo, che al confronto appare balbuziente e viene attaccato su tutti i fronti. Il fatto è che il rapporto dell’immediato con il duraturo opera in modo diverso nel nuovo teatro. Shakespeare può scrivere Shylock, bestiale e folgorante allo stesso tempo; se lo facesse un contemporaneo, non scamperebbe dall’essere considerato un fanatico nazista che attacca gli ebrei. Il contemporaneo si fa carico di tutta la prospettiva, precedente e attuale. Anche il classico, però a volte preferiamo ignorare quella prospettiva e far funzionare la macchina in modo che il dibattito avvenga in modo civile. Strindberg era misogino? È importante? Va detto chiaramente: ad un autore contemporaneo non sarebbe permesso, nel bene e nel male.
Il dibattito culturale, come il teatro, se è “qui e ora” ha bisogno di un “qui” e un’”ora” chiari, e questa è materia del contemporaneo. Ma cos’è il contemporaneo? Il testo, la sua esecuzione, il suo linguaggio, le sue idee, le sue metafore? È qui che la nozione di post-drammatico diventa davvero interessante, ovvero quando sostiene che si può immaginare e concepire un teatro che non derivi necessariamente da un testo scritto a priori che viene portato alla luce, ma da un gruppo attivo di artisti irrequieti. Confrontiamoci con ciò che accade nelle arti plastiche, per esempio: nessuno penserebbe di chiedere ad un artista visivo di imitare il modo di rappresentazione di un classico; il valore di ciò che fa risiede direttamente nella sua audacia o nella sua originalità, nell’essere in grado di spostare l’attenzione su un tema senza cadere nella ripetizione. Le arti che utilizzano la parola si trovano in una situazione meno chiara. Il testo (l’idea) è ancora predominante rispetto alle altre aree della nostra specificità teatrale, ad esempio la recitazione. Per me la recitazione è come una locomotiva, potente e imponente, che non serve solo ad “illustrare” la bontà del testo (sia esso scritto prima o durante). La recitazione è in grado di interrogare profondamente le idee, le ideologie, i limiti del pensiero. E la sua comprensione è diretta e immediata. Ma raramente troviamo spazi come questa intervista in cui possiamo parlare del potere dell’azione (che può anche andare contro lo status morale del testo); quasi sempre – dal momento che parliamo con le parole – ci si aspetta che sia la drammaturgia (le parole del teatro, o la loro organizzazione scritta) a portare novità e nuova linfa al teatro. In Argentina abbiamo assistito alla nascita di una generazione di attori/intellettuali di grande valore che hanno assunto la recitazione come un’arte pura, rivelatrice e vorace. Questi attori e attrici hanno ispirato la nascita di un mondo, di una nuova drammaturgia locale, che non si considera letteratura, ma arte vivente.
Dal continuo susseguirsi degli atti che costituiscono quest’arte vivente ci si può attendere un dibattito pubblico di un certo interesse e di una certa rilevanza. Per molti di noi scrivere è una gioia vitale.
Tuttavia, vorrei relativizzare il successo o la portata di questo presunto dibattito pubblico negli stupidi tempi in cui viviamo. Guardate il caso degli Stati Uniti: nessuno dubita che vi siano intellettuali o filosofi di enorme talento, addirittura alcuni di loro non hanno paura di dire ad alta voce come la pensano, ad esempio Noam Chomsky o – per rimanere vicini al teatro – un drammaturgo squisito come Wallace Shawn. Questo è servito a minare il successo di un Donald Trump, per esempio? Poco o niente. Anzi, niente. O forse funziona semplicemente come ho sentito dire a Siri Hustvedt: l’americano medio ha già capito cosa è buono e cosa è giusto, solo che non gli importa. Il trionfo dell’”a-critico” non è mai stato così esplicito come in quest’epoca. Il capitalismo ha condotto anni di intensa militanza in questo senso. Oggi finanzia odiatori, troll, fake news. Pensate a quanto è schifoso il capitalismo che si abbassa ad usare questi strumenti. E pensate quanto successo ottiene attraverso un piano così grezzo e ridicolo. Poco può fare il teatro su questo punto quando non funziona nessuno dei dispositivi progettati per migliorare il nostro rapporto con il pianeta e con noi stessi.
Anche la recente pandemia porta novità in questo cosiddetto dibattito. Di cosa dovremmo discutere? Sapete che il mare si sta acidificando a passi da gigante? Le alghe che producono il nostro ossigeno è molto probabile che in breve tempo moriranno, lo sapete? Vedete la questione sulle prime pagine dei giornali, vedete i vostri politici difenderci da questo destino tragico? Discutiamo dei temi di cui il sistema vuole che discutiamo. Foucault ce lo ha detto molto tempo fa e noi non siamo ancora stati in grado di rispondergli nulla.
Ha dei modelli drammaturgici di riferimento?
Modelli o autori? Beh, sì e no; ci sono autori che mi piacciono e che mi emozionano, ai quali posso tornare in ogni momento. Anche se non ho intenzione di fare quello che fanno loro, è sempre confortante leggere Čechov, Carver, Joyce, Sartre, Müller, Brecht, Beckett, Fassbinder. Forse il mio autore preferito è Harold Pinter, che ho avuto l’enorme piacere di incontrare e di tradurre in spagnolo per l’America Latina. Ma se parliamo di riferimenti, penso che il dialogo (a volte muto) con i miei colleghi e con i miei contemporanei sia più importante. Capita spesso che alcuni testi presentati in un momento preciso ci facciano immaginare di risponderci l’uno con l’altro: una rete concettuale molto attiva che trovo più attuale e stimolante rispetto al peso inavvicinabile dei classici della mia biblioteca. In questa lunga lista devo includere i miei vicini più prossimi (Javier Daulte, Daniel Veronese, Andrea Garrote, Mauricio Kartun, Mariano Llinás, Mariano Pensotti, Alejandro Tantanian, Alejo Moguillansky, Lola Arias, Matías Feldman, Marilú Marini) e anche alcuni autori provenienti da paesi più lontani, il cui lavoro è sempre un punto di dialogo e ispirazione (il ceco Petr Zelenka, Marius von Mayenburg, Sarah Kane, Mark Ravenhill, Constanza Macras, Martin Crimp, Tom Stoppard, Wallace Shawn, Alberto San Juan, Sanchis Sinisterra, l’uruguayana Denise Despeyroux, l’argentino Guillermo Pisani che vive a Parigi, la compagnia belga Transquinquennal, il canadese Anthony Black).
Se invece parliamo di modelli, le cose diventano più interessanti, perché devo ammettere che i miei modelli drammaturgici ultimamente provengono dalla biologia o dalla fisica piuttosto che dalla drammaturgia stessa. Mi piace pensare all’arte drammatica come a una forma di creazione di vita virtuale, e in questo senso ho iniziato ad interessarmi a modelli che siano a loro volta biologicamente stabili, vale a dire, che siano vivi e che assumano il potenziale catastrofico insito nella creatività. Ecco perché di solito trovo modelli su cui lavorare in letture non teatrali (come libri di filosofia) e anche in modelli narrativi non teatrali, come film, melodramma, il calcio o alcune serie.
Come costruisce i suoi testi teatrali?
A questo non posso rispondere in maniera univoca ed esaustiva. Sintetizziamo dicendo che mi interessa un teatro che costruisca non solo un testo ma anche un linguaggio.
Mi preoccupo che sia biologicamente complesso, contro l’idea riduzionista della linearità, che mi è in qualche modo estranea. E capisco anche che la missione di ogni costruzione che affronto deve tendere a moltiplicare il senso che la circonda e non alla mera realizzazione dei significati che espone.
Sono stato etichettato un po’ come un architetto di catastrofi e il soprannome non mi offende affatto, anche se credo piuttosto di perseguire uno sviluppo di forme simili a quelle del frattale in matematica.
Quando compone un testo, predilige ritagliarlo su uno o più interpreti specifici oppure crea i personaggi al di là degli attori che li interpreteranno?
Mi ha sempre aiutato molto sapere chi fosse l’attore che avrebbe indossato l’abito che stavo cucendo. La mia immaginazione migliora quando la mia poetica “incrocia” quella di un particolare attore. Questa forma di scrittura, che è la forma ideale sotto molti aspetti (e che – ci sembra – usava anche Shakespeare per gli attori della sua compagnia) si è persa più volte nella storia del teatro perché i sistemi di potere della cultura hanno cercato di dare all’autore o al regista più peso poetico rispetto agli attori: il potere trova sempre più facile negoziare con un singolo individuo che con una collettività. La collettività è potente e imprevedibile. Agisce metonimicamente come popolo, mentre un singolo individuo è corruttibile, come un leader sindacale. Mi lascio permeare profondamente dagli elementi umani con cui ho intenzione di lavorare. Il teatro è un’arte profondamente collettiva, che guadagna densità quanto meno è piramidale, nelle sue operazioni di creazione.
La contaminazione tra vari linguaggi, drammaturgia, scrittura cinematografica, televisiva etc…, depaupera il puro teatrale o aumenta il ventaglio delle possibilità?
Non esiste il “puro teatrale”. Il teatro è sempre stato un ibrido, una macchina che ruba cose da altri ambiti. Ha rubato dall’armonia pitagorica, dalle oscenità dei giullari, dal circo di strada, dalla danza nomade, dall’atonalità e alla dodecafonia. Questo non è mai cambiato, dai greci in poi.
Penso che il punto sia l’intelligenza con cui si verifica quel furto. Se vogliamo rubare alla televisione solo le sue sciocchezze, è meglio tenerci stretto Aristotele. Ma se vogliamo trovare bellezza, opportunità e rischio nel giardino del vicino, in modo intelligente e audace, così sia! Questo è ciò che va fatto.
Di cosa si potrà parlare quando le sale dei teatri riapriranno?
Non lo so, ma questa domanda mi riempie di gioia, dal momento che sembra supporre che secondo voi questa situazione si risolverà.
C’è chi, molto più pessimista, non ne è così sicuro. Questa nuova realtà ha finito per imporsi su quella precedente, da molti punti di vista.
Vi racconto un fatto che mi fa venir voglia di gridare: in Argentina fino al 2000 c’era molta musica dal vivo. Gruppi rock, jazz o tango suonati in bugigattoli come in grandi spazi. Andare ad ascoltare musica dal vivo era un appuntamento regolare e completamente normale. I musicisti guadagnavano di più coi concerti dal vivo che coi diritti d’autore. Dopo la tragedia di Cromañón (una discoteca mal costruita che andò a fuoco causando 194 morti) il governo iniziò ad autorizzare solo sale che soddisfacevano criteri davvero singolari, a volte corretti, altre volte offensivi e inutili; quel che è certo è che tenere aperti spazi per la musica dal vivo non è più un business redditizio. La musica dal vivo è quasi scomparsa dai nostri orizzonti. Molti si sono lamentati di questa “nuova normalità”. Eppure, eccoci qua. La musica dal vivo non è mai tornata. La musica è scomparsa anche da CD e dagli altri formati per diventare sempre più immateriale, lasciando nelle mani di Spotify e altri suoi simili la gestione del godimento (e dei diritti d’autore) di qualcosa che una volta consideravamo necessario e naturale come l’aria intorno.
Cosa ci fa pensare che il teatro non subirà un destino simile? Gli ottimisti più audaci sostengono che tornerà più forte di prima, perché il legame umano (siamo mammiferi) richiede disperatamente il contatto e la presenza fisica. Ma in alcune culture, come la nostra, questo colpo di stato è stato letale, poiché il teatro che prima veniva orgogliosamente chiamato “indipendente” ora è diventato “marginale”. La ricostruzione non sarà facile. Soprattutto per alcuni settori del teatro d’arte. E non vediamo alcun segnale di protezione da parte dello Stato. È curioso: quando a fallire sono le banche, lo Stato corre a salvarle. Ma al teatro, alla musica, a tutto ciò che è strettamente umano, viene chiesto quello che si chiede ad ogni economia: che sopravviva da sola (cosa che alle banche non è stato chiesto di fare). Io non vedo gli autori teatrali, tra sei mesi, scagliarsi docilmente contro queste avversità; credo che parleremo di altre cose. Non abbiamo molti precedenti per ipotizzare un futuro plausibile. Ma di cosa parlavano gli autori durante la peste nera, durante l’influenza spagnola? E durante la guerra? Io penso che il teatro cerchi, oltre alla presenza, l’alterità. E che se cerca di parlare di ciò che sta accadendo, a maggior ragione deve farlo in termini di espansione del campo discorsivo; deve farlo per fuggire e sfuggire a tali circostanze. Non solo per frivolezza; è il suo modo profondo di portarci altrove.
Il teatro non vuole mai stare nello spazio in cui lo relegano.
Rafael Spregelburd
11 marzo 2021